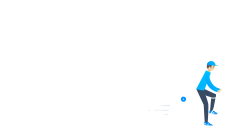L’estate amplifica le interazioni sociali servendosi, più di ogni altra stagione dell’anno, del linguaggio del corpo. Dopo mesi di lockdown, la stagione estiva diventa più che mai sinonimo di libertà, ma la fame d’aria che sentiamo si scontra con una barriera artificiale: la mascherina che portiamo sul volto. Quanto questo aspetto influenza la nostra socializzazione nel periodo dell’anno in cui, per definizione, siamo più esposti al contatto con l’altro? Lo abbiamo chiesto al dottor Massimo Bertoli, psicologo specializzato in psicoterapia cognitiva-neuropsicologica.
“Il filosofo Heidegger dice che l’essenza dell’essere umano risiede nell’abitare il mondo insieme agli altri. Non sorprende, quindi, che l’epidemia vada a toccare un aspetto fondamentale della nostra esistenza, cioè quello relazionale, emerso per contrasto durante il lockdown, quando il rapporto con il mondo si è letteralmente interrotto. La fase che stiamo vivendo si sovrappone ora alla bella stagione, che nella nostra cultura è sinonimo di vacanze e dello stare insieme.
Tuttavia, il ritorno alla socialità risulta ancora mediato dai dispositivi di protezione individuale, che limitano - pure se per un valido motivo - quella spontaneità che accompagna il nostro rapporto con il mondo. Una limitata spontaneità rende il mondo, di conseguenza, un luogo in cui sì incontriamo gli altri, ma in modo più scomodo e faticoso”.
La fisionomia del singolo è alla base della riconoscibilità reciproca. Quanto una mascherina può privarci della nostra individualità? Può rappresentare il paradigma di una moderna crisi d’identità, sul modello pirandelliano di “Uno, nessuno e centomila”?
Il volto e gli elementi che lo compongono hanno un ruolo fondamentale per l’essere umano, soprattutto per quanto riguarda la dimensione relazionale e emotiva, al punto che possediamo aree cerebrali dedicate alla sua elaborazione. Inoltre, fin dalle prime ore di vita, il neonato mostra una preferenza per le configurazioni che richiamano il volto umano, che durante lo sviluppo diventerà sempre più il “luogo” in cui avviene l’incontro con l’Altro.
Quest’abilità innata ci permette di capire fin da subito che il volto degli altri è importante in primis per la nostra sopravvivenza e, in secundis, per la nostra partecipazione al mondo. L’utilizzo della mascherina che copre buona parte del volto rappresenta sicuramente un modo di stare insieme alterato a cui non siamo abituati ma credo che, grazie al significato attributo a questo dispositivo e alla consapevolezza della temporaneità della situazione, il suo utilizzo non sia in grado, da solo, di minacciare la stabilità della nostra identità.
Si tratta, più che altro, di trovare modi appropriati per ricostruire quella parte di mondo che la mascherina ci ha tolto. In questo senso, un esempio può essere l’idea di utilizzare mascherine trasparenti che facilitino la lettura labiale per i non udenti. Tuttavia, senza un contesto adeguato, la mascherina potrebbe rappresentare un elemento eccessivamente intrusivo e destabilizzante che potrebbe a sua volta aprire la strada a scenari che si avvicinano a quello immaginato da Pirandello.

Qual è stato l’impatto psicologico sulle personalità più fragili?
La pandemia si è riflessa in modo diverso anche nella psicopatologia e nella sintomatologia: per esempio, alcuni comportamenti patologici - pensiamo all’ossessione da contaminazione - potrebbero essersi rivelati perfettamente adatti alla situazione, anzi utili. Altre persone invece, differenziando tra i contesti, potrebbero aver sviluppato sintomatologie fobiche e claustrofobiche riconducibili alla limitazione della libertà personale e quindi delle possibilità di esistere in modi diversi da quelli prescritti in questo periodo.
Ma è il contesto a fare la differenza: tenendo conto dell’unicità di ogni essere umano, è possibile costruire una narrazione di questo periodo che raccolga le esperienze inedite e le emozioni che le hanno accompagnate all’interno di una cornice di senso identitaria. Quando questo non è possibile, la realtà può tingersi secondo emozioni che mettono in scacco la nostra identità.
Le ormai note mascherine chirurgiche, FFP2 o FFP3 sono state sostituite da un mezzo di affermazione della propria individualità: la mascherina personalizzata. Quanto questo elemento rappresenta il bisogno di una riaffermazione della nostra identità?
La mascherina e le politiche adottate riducono i modi in cui è possibile realizzare il rapporto con il mondo, oltre a limitarne la qualità. A mio parere, l’idea di personalizzare la mascherina rappresenta un ottimo modo per restituire un po’ di quella vivacità dell’esperienza a cui abbiamo rinunciato in cambio della sicurezza. Così, una mascherina personalizzata può ancora sorprenderci, proprio come le persone che la indossano, e questo è fondamentale per il nostro benessere psicologico, poiché ci ricorda che dietro quella mascherina c’è qualcuno come noi ma diverso da noi.
Se da un lato l’uso delle mascherine ha minato la nostra individualità, dall’altro ci ha liberato dal peso di indossare delle maschere di circostanza. L’esperienza della pandemia può essere alla base di nuovi rituali sociali in cui la comunicazione risulta più vera?
Il linguaggio è ciò che distingue l’uomo dagli altri esseri viventi e racchiude in sé gli aspetti costitutivi del nostro essere, ovvero il rapporto con il tempo, con gli altri e con il mondo in cui viviamo. Grazie a Zoom, Skype e alle videochiamate, durante il lockdown il mondo reale ha continuato a esistere e noi con lui.
Se, da un lato, l’esperienza della pandemia ha messo in luce le difficoltà di comunicare rinunciando a una parte di comunicazione non verbale, dall’altro ci ha insegnato che è necessario prestare attenzione al fatto che le parole appartengono a un mondo che già esiste e che abitiamo. Rimettere le parole a contatto con la vita e con le nostre esperienze è una pratica da favorire, poiché costituisce la base di un cambiamento che porterà ad una comunicazione più vera perché “più umana”.